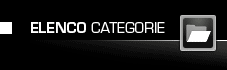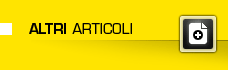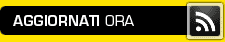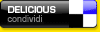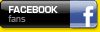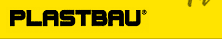Nell’ultimo decennio la tematica dell’efficienza energetica degli edifici ha acquistato sempre più importanza per la riduzione del fabbisogno energetico dei Paesi Europei. Nello specifico il comparto dell’edilizia è responsabile del 40% del consumo globale di energia nell’Unione Europea . L’UE ha indicato, ai Paesi membri, la strada da percorrere con la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive.
Nell’ultimo decennio la tematica dell’efficienza energetica degli edifici ha acquistato sempre più importanza per la riduzione del fabbisogno energetico dei Paesi Europei. Nello specifico il comparto dell’edilizia è responsabile del 40% del consumo globale di energia nell’Unione Europea . L’UE ha indicato, ai Paesi membri, la strada da percorrere con la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive.
Per quanto riguarda l’Italia, per raggiungere livelli alti di efficienza energetica dovrà tagliare il 13% di emissioni di C02 nei settori non inclusi nel sistema di scambio di emissioni e dovrà aumentare del 17% i consumi energetici da fonti rinnovabili entro il2020, rispetto ai livelli del 2005. Analizzando lo stato del parco edilizio italiano, l’ENEA (www.enea.it) stima che il patrimonio ammonti a 11.600.000 edifici residenziali, dei quali circa il 65% edificato prima degli anni ’80.
Tra gli obiettivi principali, al fine di limitare i consumi energetici, vi è quindi la necessità di recuperare l’esistente non ancora sottoposto ad interventi di ristrutturazione o manutenzione edilizia da almeno 20 anni. Riguardo agli edifici del terziario, si ha invece una conoscenza relativamente critica e carente, se non limitatamente ad alcune categorie come ad esempio uffici, scuole ed alberghi.
 Sulla base di questa fotografia, l’ENEA ha evidenziato i principali interventi per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, rapportati agli investimenti con una valutazione qualitativa del tempo di ritorno del capitale investito, che tenga conto della loro sostenibilità sotto il profilo dei costi così come richiesto nell’ultima direttiva europea.
Sulla base di questa fotografia, l’ENEA ha evidenziato i principali interventi per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, rapportati agli investimenti con una valutazione qualitativa del tempo di ritorno del capitale investito, che tenga conto della loro sostenibilità sotto il profilo dei costi così come richiesto nell’ultima direttiva europea.
Secondo questa analisi gli interventi più costosi con un tempo di ritorno più lungo, sono quelli edilizi (sostituzione degli infissi, introduzione e manutenzione di elementi schermanti fissi, isolamento dei componenti d’involucro, introduzione di tecnologie bioclimatiche). Le tecnologie a medio costo con tempo di ritorno dai 6 ai 12 anni riguardano invece gli interventi impiantistici (coibentazione di tubazioni esterne per il riscaldamento, sostituzioni del generatore di calore, introduzione di impianti di climatizzazione ad alta efficienza, e di illuminazione integrati con le fonti rinnovabili e inserimento di impianti solare termici e fotovoltaici). Mentre gli interventi a medio costo risultano essere la regolazione con valvole termostatiche, la sostituzione delle lampade tradizionali con lampade ad alte prestazioni, il ricorso a strutture intelligenti integrate per la gestione e la regolazione degli impianti.
 A fronte dell’analisi relativa ai consumi di energia, sono state presentate possibili soluzioni per costruire un edificio “ad energia quasi zero” avanzando delle proposte tra cui incentivazione degli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, la definizione del concetto di edificio a “energia zero” per gli edifici esistenti legato al parametro costi-benefici e in ultimo standard più severi per gli edifici di nuova costruzione.
A fronte dell’analisi relativa ai consumi di energia, sono state presentate possibili soluzioni per costruire un edificio “ad energia quasi zero” avanzando delle proposte tra cui incentivazione degli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, la definizione del concetto di edificio a “energia zero” per gli edifici esistenti legato al parametro costi-benefici e in ultimo standard più severi per gli edifici di nuova costruzione.
Fonte: Ufficio stampa di Aipe